Con il naufragio del Mondo Antico non crollano rovinosamente solo le istituzioni politiche ed economiche della civiltà Greco/Latina, ma anche gran parte della straordinaria cultura raggiunta fino a quel momento dal nostro Occidente. Il Medioevo, così, ignora gran parte degli straordinari livelli di conoscenza acquisiti dagli antichi, ritrovandosi dunque a ripartire da un stadio culturale nettamente inferiore, rispetto appunto all'antichità classica, con costumi, usi, consuetudini e modelli tornati spaventosamente rozzi e barbarici.
Gli intellettuali medioevali, allora, pian piano, riprenderanno la strada per riappropriarsi di buona parte di quella conoscenza perduta e solo dopo secoli tutto questo processo giungerà a mostrare i suoi frutti (XII- XV secolo).

Tuttavia, col tempo, sebbene la cultura Latina ritornerà ad affermarsi nel nostro Occidente (anche se in alcune zone, come l'Italia, essa non andrà mai veramente perduta), le cose andranno in modo diverso per quanto riguarda la cultura Greca.
Questo a causa della sostanziale e quasi assoluta ignoranza nell'Occidente Latino della lingua greca, conoscenza, questa, andata perduta proprio alla fine del Mondo Antico.
Severino Boezio per questo aveva a lungo cullato l'ambizioso intento di tradurre in latino tutto Aristotele e tutto Platone, progetto fallito a causa della disgrazia abbattutasi sul grande intellettuale.
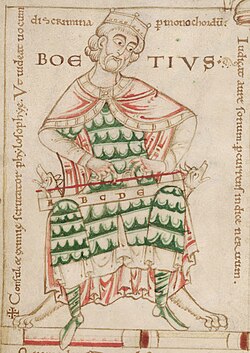
Tuttavia, fino all'avvento delle traduzioni arabe in Occidente, Aristotele e Platone, anche se in minima parte, saranno conosciuti proprio grazie a questo lavoro di Boezio.
E appunto, per avere un'immissione massiccia e completa del pensiero di Aristotele nell'Europa Occidentale, bisogna attendere le traduzioni che proprio gli arabi fecero dal greco.
E così, nel XIII Secolo, avviene la grande rivoluzione culturale, che immettendo la dottrina aristotelica non solo nella filosofia e nella teologia, ma anche nel metodo di indagine e di studio che caratterizza il pensiero Occidentale, influenzando in maniera totale il modo di approcciarsi al sapere ed alla sua divulgazione, stravolge completamente la società dell'Europa Latina.
Queste traduzioni, giunte da noi in seguito alla conquista araba del Mediterraneo e della penisola Iberica, sono spesso accompagnate da commenti e glosse, rendendo ancora più particolare questo impatto del cosiddetto “Aristotele Latino” sulla nostra cultura.
Celebre, ad esempio, è il commento del filosofo arabo Averroè, citato anche da Dante Alighieri.

Tutto questo, come detto, scuote le fondamenta del pensiero Occidentale, trovando un fertile campo per germogliare soprattutto in ambienti universitari e scolastici.
E la rivoluzione culturale è totale.
Viene messa in dubbio, per la prima volta, “l'Autoritas”, ossia il binomio Testi Sacri-Padri della Chiesa e tutto viene dunque sottoposto ad un nuovo metodo di interpretazione.
I nemici della Tradizione e della Fede trovano così, nel pensiero aristotelico, un'arma potentissima per attaccare la cultura Cristiana e le autorità ecclesiastiche, tanto che i vertici della Chiesa più volte ammoniscono i fedeli dal seguire tali pericolose seduzioni.

Tuttavia, questa allarmante visione della situazione sembra in qualche modo non convincere una parte delle autorità ecclesiastiche.
I grandi maestri Domenicani, infatti, soprattutto nella figura di San Tommaso D'Aquino, il più grande filosofo medioevale e tra i più grandi di ogni tempo, non riescono a concepire come Aristotele, uno dei più grandi geni di ogni epoca, possa rivelarsi nocivo per la Fede Cristiana, che invece, al contrario, dovrebbe trarre forza da ogni forma di conoscenza.

San Tommaso riteneva impossibile che la Fede, perfetta ed assoluta, potesse in qualche modo temere pericoli o attacchi da parte di dottrine, come la filosofia e la teologia, nate invece per il suo studio e la sua comprensione.
I domenicani, così, decidono, a differenza del resto del mondo Cattolico, di combattere i nemici della Tradizione sul loro stesso campo, ossia lo studio di Aristotele.
Bisognava allora sottoporre l'intero pensiero di Aristotele ad un nuovo studio e ad una nuova analisi.
E per questo bisognava partire, per forze di cose, da quelle traduzioni arabe che avevano permesso all'Occidente Latino di conoscere finalmente le opere del grande filosofo greco.
San Tommaso e gli altri grandi maestri dell'ordine vedevano però in modo poco chiaro il corpo di queste traduzioni arabe; occorrevano dunque nuove traduzioni, stavolta più chiare, tradotte direttamente dal Greco al Latino.
Un'impresa titanica per quei tempi, ma doverosa, secondo lui, per conoscere in pieno il pensiero di Aristotele.
Egli incarica, allora, il suo confratello ed esperto di lingua greca Guglielmo di Moerbecke di tradurre in Latino Aristotele direttamente dalla sua lingua madre, senza la mediazione araba.

Guglielmo e i suoi collaboratori, così, mettono mano ad un grandioso lavoro di traduzione, dando al nostro Occidente una visione diretta, senza più l'intervento arabo, del pensiero aristotelico.
E in maniera sorprendente si scopre, così, come le traduzioni arabe di Aristotele siano tutt'altro che attendibili, infarcite di alterazioni ed errori sia involontari che volontari.
E cosa ancor più stupefacente, tutto questo trasforma Aristotele da nemico della Fede a vessillo di quest'ultima.
Infatti, riportando alla sua reale visione il pensiero del grande filosofo greco, i maestri domenicani, sconfessando gli alterati procedimenti aristotelici nati sullo slancio delle incerte traduzioni arabe, lo utilizzano come un potente strumento cognitivo da utilizzare per assicurare le argomentazioni della Fede.
In pratica giunge a compimento quel grandioso processo che iniziato sotto Sant'Agostino e continuato con Boezio, Cassiodoro, Isidoro di Siviglia e Beda il Venerabile, trasmetterà e tramuterà l'intera cultura classica in quella Cristiana medioevale, gettando così le basi della nostra cultura occidentale moderna.

Il grande scrittore Lattanzio scriveva: “Ogni disciplina e dottrina conosciuta, sia essa umana (ossia legata alle Lettere), sia essa naturale (ossia scientifica), altro non è che una costante ed infallibile testimonianza della perfezione della Creazione Divina.”
Concetto riaffermato dai più grandi studiosi di ogni tempo, come Alano di Lille, Gian Battista Vico, Galileo Galilei.
